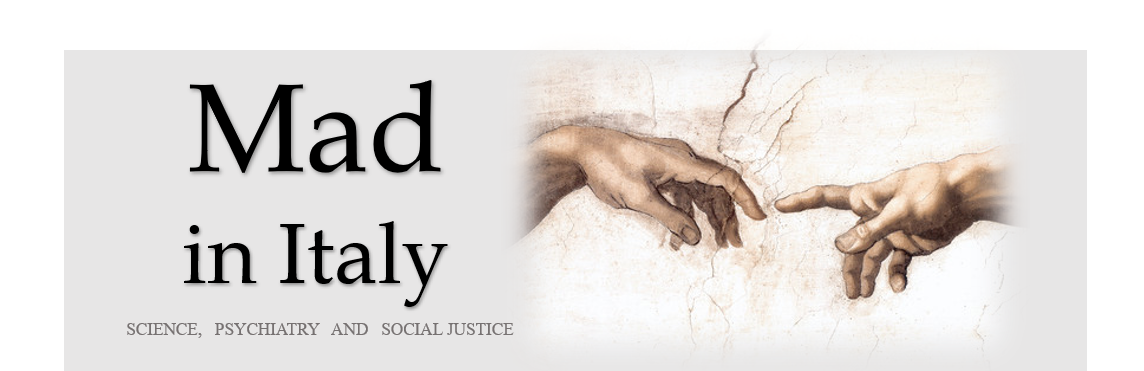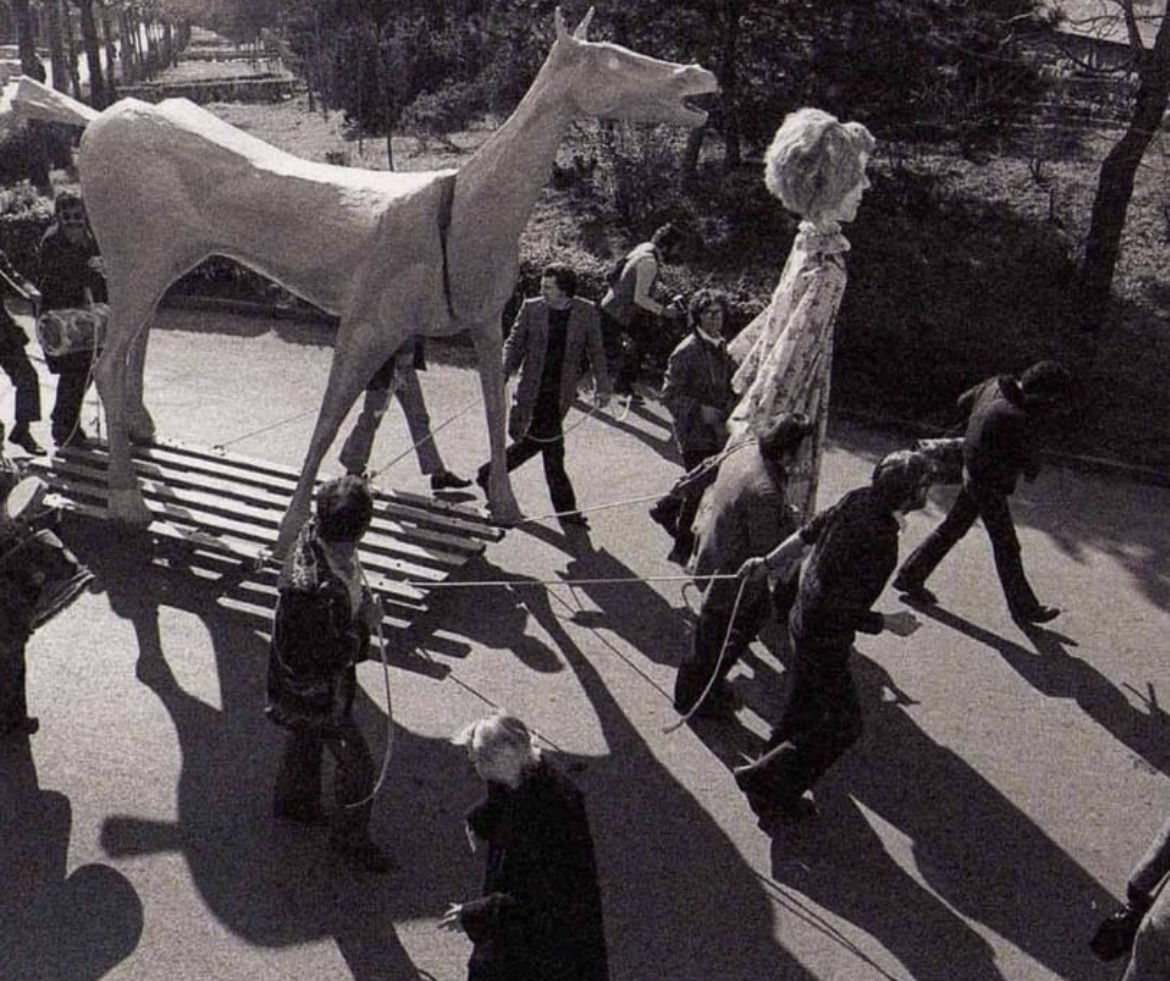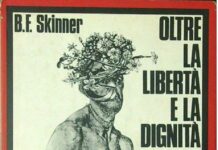- Chiaroscuro basagliano – La crisi della Psichiatria - 19 Marzo 2025
- Positivismo e Psichiatria – La Scienza del Committente - 17 Aprile 2023
- Che cosa succede in Italia? - 24 Luglio 2021
Chiaroscuro basagliano – La crisi della Psichiatria
La profonda crisi in cui versa la psichiatria italiana è sempre più evidente. In questa mia relazione, dopo aver esaminato i mali che l’affliggono, cercheremo di individuare le cause e i possibili rimedi.
I mali
- È sotto gli occhi di tutti che la psichiatria italiana è tra le più povere al mondo: nel nostro paese la quota di spesa sanitaria dedicata alla salute mentale è in coda alla classifica internazionale (1).
- Il servizio pubblico riceve meno della metà di quanto viene stanziato per l’assistenza psichiatrica. Nel Lazio, come riportato da Daniela Pezzi, storica volontaria Caritas ed ex-presidente della Consulta regionale per la salute mentale (dimissionata da Zingaretti) (2), addirittura il 70% del denaro pubblico destinato alla psichiatria finisce nelle mani dei privatii (3).
- Nella nostra nazione, circa 400 mila concittadini (350.000 nel 2023 secondo un articolo del giornale “il post” ma è solo un dato ipotetico, poiché non esiste un registro nazionale) (4) sono sottoposti ad amministrazione di sostegno. La legge Cendon non pone limiti all’applicazione della “delega della cura”, al punto che la Magistratura stessa si è trovata a darsi linee guida, per auto regolamentarsi su una questione così spinosa (5). Gli amministrati sono privati del diritto di gestire le proprie finanze e possono essere ricoverati e istituzionalizzati in qualunque momento, sulla base del giudizio insindacabile dell’amministratore di sostegno, convalidato dal Giudice Tutelare, arrivando troppe volte a doversi pagare la cura (leggasi internamento) di tasca propria, come nel caso dell’inserimento nelle RSA. Tutto questo avviene senza la necessità di percorso valutativo approfondito come avviene nelle precedenti forme di tutela.
- I servizi psichiatrici territoriali sono organizzati in gran parte dei casi secondo un modello di intervento di tipo ambulatoriale, dove l’utente, spesso dopo una lunga di attesa, viene curato con un approccio essenzialmente farmacologico. Le visite domiciliari sono un’eccezione e non la regola.
- La psicoterapia offerta dal servizio pubblico, di regola segue un approccio di tipo cognitivo/comportamentale, finalizzato sostanzialmente all’accettazione della malattia e della necessità di assumere terapie farmacologiche a vita. Altri tipi di approccio sono raramente disponibili e sovente dichiarati inutili, specialmente quelli di tipo sistemico e psicodinamico, che invece possono essere di valido aiuto per modificare in modo sostanziale il disagio.
- La scarsa qualità delle cure sta portando a una progressiva cronicizzazione del disagio mentale, con un progressivo aumento degli utenti che, una volta “arruolati” vengono sottoposti a vita alle terapie farmacologiche. Attualmente, dieci milioni di italiani sono sottoposti a trattamenti farmacologici con sostanze psicotrope e il loro numero è destinato ad aumentare se non si prendono provvedimenti (6). Tale condizione si è significativamente aggravata dopo l’epidemia di Covid, come prevedibile (7).
Quali le cause
La risposta va trovata nel combinato disposto della legge 180 del 1978 e della legge 6 del 2004. La psichiatria italiana è nota in tutto il mondo per il carattere innovativo delle cure offerte, essendo il nostro il primo paese in cui è stato vietato l’obbligo dell’internamento degli utenti negli ospedali psichiatrici. La camicia di forza e la decontenzione sono stati i punti di forza della riforma.
Ma a quale prezzo?
L’interazione tra la Legge 180 e la Legge 833 ha creato un quadro normativo che ha rivoluzionato la salute mentale in Italia ma che ha contribuito al degrado delle condizioni dell’assistenza in tal campo. La legge 180 nasce in un momento di grande fervore degli studi sugli effetti dei farmaci psicotropi sul comportamento umano: neurolettici, antidepressivi, stabilizzatori dell’umore, sono stati introdotti proprio in quegli anni dall’industria farmaceutica. C’era all’epoca l’idea che bastasse trovare la molecola giusta per risolvere ogni forma di disordine mentale. Lo stesso Basaglia nei suoi scritti, se da un lato già metteva in guardia dal rischio che le nuove molecole venissero utilizzate per una risposta apparentemente esaustiva del disagio, dall’altro non nascondeva il suo entusiasmo per questi farmaci (“La terapia farmacologica ha dato ovunque risultati sorprendenti e sconcertanti insieme (Basaglia, p. 158) (8).
La legge 180 (il cui testo tra l’altro non è stato concepito da Basaglia, ma da uno psichiatra genovese di ambito democristiano, Orsini) è dunque impregnata dal convincimento, diffuso all’epoca, secondo il quale gli psicofarmaci agissero su alterazioni cerebrali, ignote ma correggibili dai medicinali somministrati. In passato si assimilava la sofferenza mentale a malattie endocrine come il diabete: al pari dell’insulina, gli psicofarmaci dovevano riequilibrare un deficit o un eccesso di neuromediatori, quali serotonina, dopamina, adrenalina. Da questo assunto nacque l’idea che fosse giusto curare i pazienti anche contro la loro volontà, in quanto inconsapevoli di una malattia del loro cervello, per la quale bastavano pochi giorni di ricovero ospedaliero, seguito da assistenza territoriale. È questo il motivo per cui è prevalsa la linea della prescrizione dell’obbligo del ricovero, il famoso trattamento sanitario obbligatorio (TSO), attualmente oggetto di critiche da parte della stessa Corte di Cassazione (9). Si riteneva che ci fosse una malattia al cervello e che bastasse somministrare i giusti farmaci.
Le ricerche successive hanno tuttavia escluso la presenza di alterazioni a carico dei neurotrasmettitori coinvolti nella cura farmacologica della psicosi, anzi, gli psicofarmaci, se assunti per lunghi periodi, possono causare dei danni organici al cervello, la c.d. CBI (Chronic Brain Impairment, CBI) (10), le cui conseguenze sono facilmente confondibili con la malattia mentale, specialmente nel caso di una brusca sospensione della terapia (11). La sospensione degli psicofarmaci richiede inoltre ben precise conoscenze (12).
La semplificazione riduzionista del disagio mentale ha portato a sottolineare eccessivamente l’importanza delle cure farmacologiche e a privilegiare un approccio medicalizzante e positivista: la scarsa efficacia di questo approccio però ha portato a un aumento progressivo del numero degli utenti seguiti e al rischio di un’implosione dei servizi psichiatrici, sottoposti a carichi di lavoro progressivamente più intensi. È questa la base su cui è nata la legge 6 del 2004, germogliata proprio nel cuore basagliano della psichiatria italiana, a Trieste, per sostenere le prassi in essere. Per obbligare gli utenti era necessario contenere ulteriormente la loro liberà, oltre a quanto già imposto dal quadro normativo della 180. Ecco perché in Italia costa così poco la psichiatria! La contrattazione con gli utenti richiede soldi e tempo mentre e la legge Cendon ha ridotto drammaticamente i gradi di libertà di coloro che erano già sottoposti alla 180! Questo ha determinato l’istituzionalizzazione di prassi in cui una presunta umanizzazione della cura ha favorito l’avvio di un sistema ospedalocentrico, incentrato su terapie farmacologiche croniche e prevalentemente a rilascio prolungato, cliniche private, cooperative sociali etc., tutti luoghi in cui la somministrazione del farmaco è considerata prioritaria mentre tutto il resto è troppo spesso un semplice corollario.
Un’altra conseguenza dell’approccio basagliano è stata l’aver privilegiato gli aspetti sociali del disagio mentale, senza dare il giusto risalto al valore alle problematiche psicologiche. Basaglia riteneva che la psicoanalisi, concentrandosi sull’individuo isolato, trascurasse l’importanza del contesto sociale nella genesi e nella manifestazione della malattia mentale. Questo ha determinato la scarsa valorizzazione di un approccio adeguato a una questione complessa come quella della salute mentale. Il file rouge del suo pensiero si fonda sul convincimento che le cause della sofferenza mentale andassero ricercate nei fattori sociali, in primis quelli di una cultura che privilegia la produttività su altri aspetti qualificanti della vita umana. L’Autore afferma infatti che “L’istituzione totale, e l’ospedale psichiatrico in particolare, è un luogo di esclusione, di controllo, di annullamento dell’individuo. Essa non cura, ma reprime, non riabilita, ma emargina” (13): encomiabile presa di posizione, che però non è esaustiva della complessità del disagio mentale.
Paradossalmente, proprio coloro che si richiamano all’eredità basagliana, investiti del compito storico di promuovere la deistituzionalizzazione, si sono arroccati nella difesa di pratiche superate. Essi hanno privilegiato la lotta alla contenzione fisica, trascurando la necessità di un approccio critico verso l’uso degli psicofarmaci. In questo contesto, va riconosciuto il ruolo pionieristico del Professor Giuseppe Tibaldi, una voce che a mio parere non ha il giusto rilievo all’interno di Psichiatria Democratica, che da anni si batte per proteggere i pazienti dai danni derivanti dall’esposizione prolungata e dall’uso contenitivo di tali farmaci. Il timore di un ritorno al passato ma soprattutto di andare contro corrente ha impedito a Psichiatria Democratica di mettere in discussione prassi ormai obsolete e di farsi promotori di una riforma della riforma, sempre più urgente. Si è preferito difendere acriticamente la legge 180, una norma all’epoca innovativa, riducendone la portata alla sola decontenzione fisica. L’appoggio incondizionato alla legge 6 del 2004 ha poi ulteriormente resa critica la condizione degli utenti psichiatrici.
Questo atteggiamento ha portato a una giusta battaglia contro la contenzione fisica, ma ha al contempo oscurato i danni derivanti da un uso miope degli psicofarmaci. Di conseguenza, mentre in altri paesi la ricerca di soluzioni innovative al disagio mentale ha compiuto progressi significativi, in Italia ci siamo trincerati in posizioni anacronistiche.
I rimedi
Una riforma delle pratiche psichiatriche deve seguire alcune linee prioritarie:
- Gli psicofarmaci, allo stato dell’arte, sono utili ma solo se si ha ben chiaro in mente che sono dei sintomatici e che la somministrazione prolungata non è priva di danni.
- Bisogna investire nella psichiatria: la libertà costa, la cura costa, i diritti costano.
- La legge 6 del 2004 è un inasprimento degli aspetti illiberali già presenti nella 180.
- In particolare bisogna porre un limite all’arbitrio e alla vaghezza dei criteri di applicazione di entrambe le norme.
- È indispensabile riorganizzare i Centri di Salute Mentale, garantendo agli utenti il diritto alla deprescrizione nelle terapie croniche e alla prescrizione di breve durata negli esordi. In quest’ottica, il mio contributo nell’ultimo libro del Professor Antonio Esposito, che consiglio vivamente, offre spunti di riflessione utili (14).
- In ogni caso è essenziale incrementare il sostegno psico-sociale del disagio mentale, favorendo la demedicalizzazione.
Note bibliografiche
- Redazione Quotidiano Sanità. Il finanziamento pubblico della Salute Mentale e la necessità di un intervento straordinario. Quotidiano Sanità.
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=104573
- Consulta Regionale per la Salute Mentale del Lazio. Lazio: dimissioni di massa della Consulta Regionale per la Salute Mentale, protesta contro la legge che prevede la nomina dall’alto dei rappresentanti di utenti e familiari. Conferenza Salute Mentale. https://www.conferenzasalutementale.it/2022/07/16/lazio-dimissioni-di-massa-della-consulta-regionale-per-la-salute-mentale-protesta-contro-la-legge-che-prevede-la-nomina-dallalto-dei-rappresentanti-di-utenti-e-familiari/ . Pubblicato il 16 luglio 2022
- Jona L. Salute mentale, il caso del Lazio: quasi 90 milioni all’anno per le rette delle strutture psichiatriche. E pochi controlli. Il Fatto Quotidiano. 2024 Mar 10. Disponibile da: https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/03/10/salute-mentale-il-caso-del-lazio-quasi-90-milioni-allanno-per-le-rette-delle-strutture-psichiatriche-e-pochi-controlli/7474190/
- Problemi amministrazione di sostegno. Il Post. 2023 Giu 26. Disponibile da: https://www.ilpost.it/2023/06/26/problemi-amministrazione-sostegno/
- Genovese D, D’Ettore MG. La “cura” e le “cure” della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno. Questione Giustizia [Internet]. 2023 [citato 2024 Giu 18]. Disponibile su: https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cura-e-le-cure-della-persona-sottoposta-ad-amministrazione-di-sostegno
- Salute mentale: i numeri dell’emergenza in Italia e in Europa. Medico e Paziente [Internet]. 2023 [citato 2024 Giu 18]. Disponibile su: https://medicoepaziente.it/2023/salute-mentale-i-numeri-dellemergenza-in-italia-e-in-europa/
- Di Munzio, Walter, Benincasa, Veronica, e Galdi, Giuseppe. Effetto lockdown. Storia di una pandemia tra cronaca ed esiti psicologici. Napoli: Marlin Editore, 2021.
- Basaglia F. L’istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico. Torino: Einaudi; 1968
- Corte di Cassazione. Ordinanza n. 24124 del 9 settembre 2024. https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/24124_09_2024_civ_oscuramento_noindex.pdf
- Breggin PR. La sospensione degli psicofarmaci. Un manuale per i medici prescrittori, i terapeuti, i pazienti e le loro famiglie. Giovanni Fioriti Editore; 2018.
- Maviglia M, Guerra L, Gandolfi M. Sospendere gli psicofarmaci: come e perché? Costruire un percorso personalizzato ed efficace. Fabbrica dei Segni; 2024.
- Horowitz MA, Taylor D. The Maudsley Deprescribing Guidelines: Antidepressants, Benzodiazepines, Gabapentinoids and Z-drugs. Chichester: Wiley Blackwell; 2021.
- Basaglia, F. (1981-1982). Scritti (Voll. 1-2). Torino: Einaudi.
- Esposito A. Come Cristo in croce. Storie, dialoghi, testimonianze sulla contenzione. Dogliani: Sensibili alle Foglie; 2024