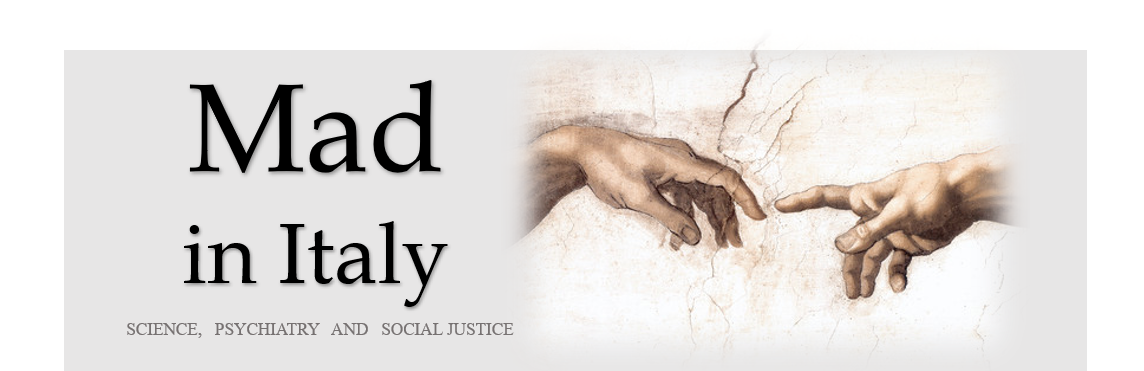- Psichiatria di precisione: promessa terapeutica o ancora riduzionismo organicista? - 27 Novembre 2025
- BENZODIAZEPINE – Utilizzo e Rischi - 8 Settembre 2025
- L’ansia paradossale dell’ansiolitico! – BENZODIAZEPINE - 7 Settembre 2025
Psichiatria di precisione: promessa terapeutica o ancora riduzionismo organicista?
Dietro la promessa della psichiatria di precisione si cela un paradigma riduzionista che, utilizzando psicofarmaci, strumenti tecnologici di elettrostimolazione e la ricerca di biomarcatori, continua a sopprimere i sintomi senza affrontare le radici della sofferenza psichica, relegando la psicoterapia a un ruolo marginale.
In un recente articolo pubblicato sul Sole 24 Ore (1), Guido Di Sciascio e Antonio Vita, nuovi presidenti della Società Italiana di Psichiatria (SIP) per il triennio 2025–2028, dichiarano:
“Dal 30% al 60% dei pazienti presenta resistenza ai trattamenti”, identificando come ‘resistenza’ la condizione che “si verifica quando un paziente non ottiene un miglioramento clinico soddisfacente dopo almeno due cicli di trattamento standard, condotti con dosi e durate adeguate”.
Per far fronte a questa supposta resistenza, secondo i due psichiatri, i trattamenti dovrebbero prevedere una serie di interventi, tra cui “farmacoterapia, psicoterapia, strumenti tecnologici e strategie di personalizzazione basate su biomarcatori e profili clinici specifici”.
Le affermazioni di Di Sciascio e Vita avrebbero fondamento solo se il modello su cui si basano i trattamenti proposti fosse realmente valido dal punto di vista scientifico.
L’importanza del modello di cura adottato
Per comprendere meglio la questione, occorre chiarire quale obiettivo si intenda perseguire: la semplice soppressione dei sintomi oppure il superamento delle cause reali della sofferenza psichica, con conseguente risoluzione dei sintomi.
Il modello adottato dalla psichiatria mainstream, rappresentata dalla SIP, è quello organicista o biomedico. Esso presuppone che i disturbi psichici abbiano un’origine biologica, organica e probabilmente genetica, e che i trattamenti farmacologici (insieme ad altri interventi) mirino a colpire tali basi organiche in modo sempre più preciso e potente.
Pur citando l’importanza degli approcci psicosociali – che tuttavia faticano a trovare spazio nella maggior parte dei CSM (Centri di Salute Mentale) – i due presidenti auspicano, ad esempio per la depressione, trattamenti integrati con strategie di augmentation (aggiunta di un altro farmaco), psicoterapia strutturata o tecniche non farmacologiche come la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
Non disdegnano, inoltre, i più recenti prodotti dell’industria farmaceutica, come “l’esketamina, indicata in associazione a un antidepressivo orale negli adulti con disturbo depressivo maggiore resistente ad almeno due antidepressivi usati correttamente”.
Per la schizofrenia viene proposto un maggiore utilizzo della clozapina, farmaco impiegato con cautela per i suoi potenziali effetti letali in una certa percentuale di casi, ma ritenuto “ottimo presidio medico” se ben monitorato.
L’articolo prosegue con il disturbo ossessivo-compulsivo, per il quale gli psicofarmaci risulterebbero inefficaci nel 40–60% dei pazienti. In questi casi, “le combinazioni di strategie di augmentation, le tecniche di neuromodulazione non invasiva – incluse la TMS e la stimolazione vagale – rappresentano direzioni particolarmente promettenti della ricerca”.
Limiti dei trattamenti proposti
A parte gli interventi psicoterapeutici e sociali, tutti gli altri menzionati (dosi crescenti di psicofarmaci o augmentation, neurostimolazione non invasiva, TMS, stimolazione vagale, esketamina, senza dimenticare l’elettroshock ancora utilizzato in alcuni CSM italiani) hanno unicamente la funzione di controllare e sopprimere i sintomi, senza incidere sulle cause reali della sofferenza psichica, radicate nei rapporti relazionali, culturali e psicosociali.
Perché allora la psichiatria “mainstream” insiste su trattamenti “di precisione”, come se si trattasse di un bisturi capace di agire con accuratezza sulla “malattia mentale”, cercando biomarcatori organici mai dimostrati?
Perché continua a promuovere la sofferenza psichica come conseguenza di squilibri chimici della serotonina, della dopamina o di altri neurotrasmettitori, e a presentare i trattamenti farmacologici come strumenti indispensabili per ripristinare un equilibrio cerebrale perduto?
È noto da tempo che la teoria degli squilibri chimici (2), diffusa negli anni ’80 dalle case farmaceutiche per promuovere gli psicofarmaci, è stata smentita e non ha alcun fondamento scientifico (3) (4).
Alla luce delle conoscenze attuali, non è corretto parlare di pazienti “responsivi” o “resistenti” ai trattamenti psichiatrici, in quanto tali trattamenti non agiscono sulle cause dei disturbi, ma agiscono in modo generico e aspecifico, producendo un distacco emotivo dalle radici della sofferenza e sedazione o, nel caso degli antidepressivi, un aumento artificiale del tono dell’umore.
Questi effetti, inoltre, sono accompagnati da numerosi effetti collaterali che possono compromettere la qualità della vita, oltre che cronicizzare i disturbi (5). Gli psicofarmaci, in particolare, inducono assuefazione e tolleranza (5), rendendo necessaria una sospensione lenta e graduale, sotto stretto controllo medico, per evitare crisi di astinenza.
Una prospettiva diversa
La sofferenza psichica, in tutte le sue forme, dovrebbe essere affrontata con interventi psicoterapeutici di qualità e, quando necessario, con interventi psicosociali.
La psichiatria, anziché specializzarsi in pratiche da “bisturi clinico”, dovrebbe fare un passo indietro e lasciare spazio alla psicoterapia, che non dovrebbe essere relegata a un ruolo subordinato.
Allo stesso tempo, gli psicoterapeuti dovrebbero recuperare la funzione centrale che la psicoterapia aveva iniziato ad assumere negli anni ’70, quando il rinnovamento della psicodinamica e l’emergere di nuovi approcci teorici e metodologici le conferivano un ruolo primario nel trattamento della sofferenza psichica (6).
Tale prospettiva, progressivamente ridimensionata negli anni ’80 dalla crescente diffusione degli psicofarmaci e dalla promozione del modello biomedico, merita oggi di essere rivalutata.
Restituire alla psicoterapia la sua dignità significa riconoscerne la capacità di affrontare le cause profonde del disagio, valorizzando la dimensione relazionale e contestuale del paziente, in un quadro integrato e complementare rispetto agli altri interventi.
Bibliografia
(3) Serotonin and depression – a riposte to Moncrieff et al. (2022) – PubMed
(6) Le parole sono scatole magiche, ma anche vuote o pericolose come trappole per topi – Mad in Italy