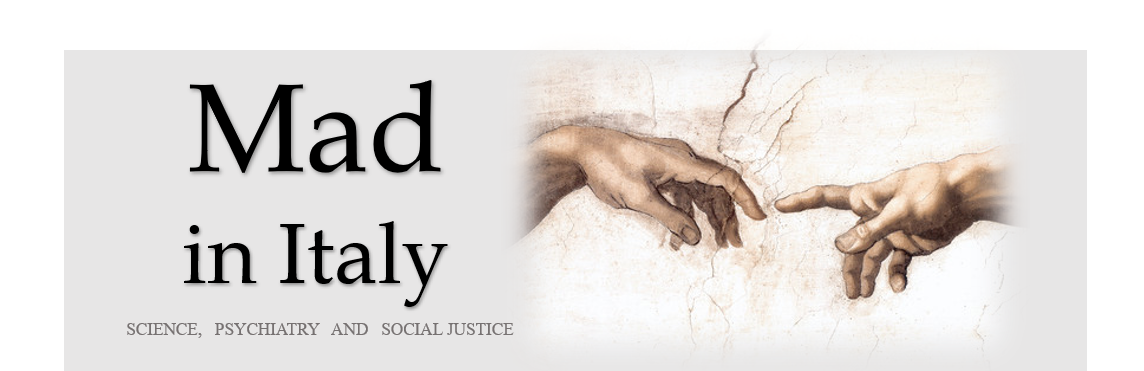- Il nuovo codice deontologico degli psicologi – Linee guida per una psicologia di Stato? - 11 Giugno 2025
- Tutte le discipline scientifiche evolvono: la psicologia non fa eccezione. Cosa cambia nel lavoro con i Pazienti? - 2 Aprile 2025
- ADHD come intervenire. Come si fa una cosa cambia la cosa che si fa - 8 Dicembre 2024
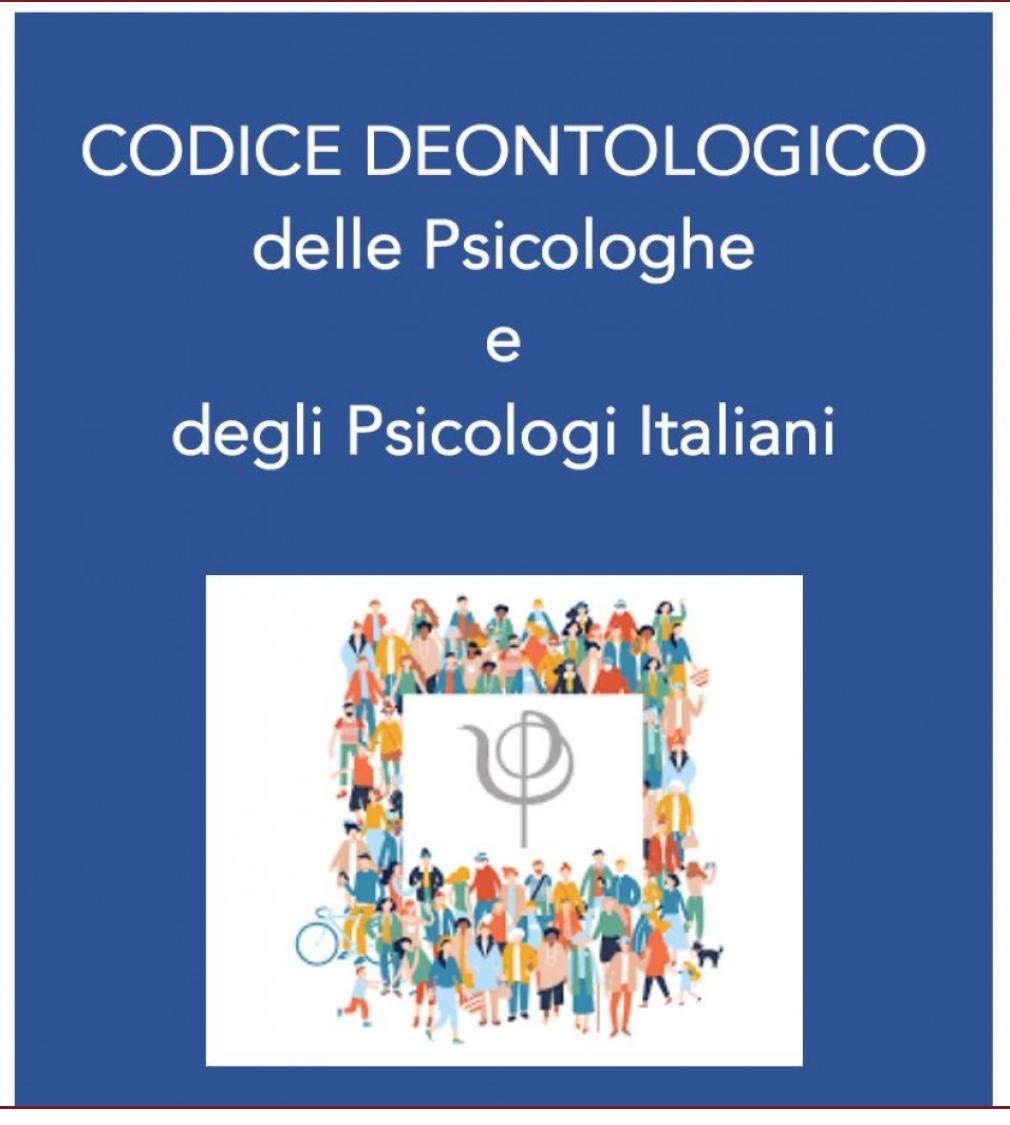
Tutte le discipline scientifiche evolvono: la psicologia non fa eccezione. Cosa cambia nel lavoro con i Pazienti/Utenti/Cittadini?
di Miriam Gandolfi, psicologa, psicoterapeuta sistemico-connessionista, Officina del pensiero, Bolzano – Trento, [email protected], marzo 2025
La discussione sul destino della proposta di nuovo codice deontologico degli psicologi non ha senso se viene estrapolata dal contesto sociale, culturale e storico più ampio che l’ha visto nascere. Ciò è infatti necessario per comprendere cosa sia un codice deontologico e, nello specifico nell’ambito della cura umana, fisica e psicologica.
In questo contesto propongo di seguire il filo che separa e insieme unisce il professionista e il paziente/utente nel percorso che ha visto la nascita della psicologia come professione di aiuto, nei diversi momenti culturali e sociali.
Infatti la relazione di aiuto è caratterizzata da una sorta di doppio legame, perché è evidente un’asimmetria insita in essa: quando si chiede aiuto ci si aspetta che colui a cui ci si rivolge ne sappia più del richiedente. D’altra parte sia il professionista che il paziente sono esseri umani che hanno lo stesso diritto al rispetto e alla tutela della libertà personale.
Per questo motivo io non amo il termine clienti, un eufemismo che altera la natura reale del rapporto d’aiuto e non garantisce il massimo impegno etico, oltre che professionale, dell’operatore.
Il primo codice deontologico in ambito medico italiano nasce a Sassari nel 1903 (testo originale trovato presso la biblioteca dell’Università di Sassari). È suddiviso in tre capitoli: il secondo, di ben trentasette articoli, parla dei doveri verso i colleghi. Analizzando il testo si comprende che esso rappresenta un correttivo alla competitività tra colleghi, tra istituzioni e al paternalismo medico, di cui quello in ambito della salute mentale è la quintessenza. Allora come ora tali aspetti erano presenti, rischiando di inquinare l’atto di cura in sé, riducendo la tutela dei pazienti, della loro salute e della loro libertà di farsi curare.
Il primo articolo recita: “Il sanitario sarà diligente, paziente e benevolo e conserverà sempre e scrupolosamente il segreto professionale. Sarà affabile coi poveri, non mostrerà ossequio servile verso i ricchi e curerà gli uni e gli altri con la stessa abnegazione”. L’Art. 4 afferma che il Medico “non intraprenderà alcun atto operativo senza aver prima ottenuto il consenso dell’ammalato o delle persone dalle quali dipende …”.
Con ciò il medico rivendicava a sé la qualità di garante del diritto del cittadino in rapporto alla necessaria tutela della salute pubblica. Ma la cosa ancora più interessante è che esso è antecedente al Regio decreto che istituiva l’Ordine Professionale dei Medici, che è del 1910; a dimostrare che il rispetto dell’agire in scienza e coscienza è più forte di ogni corporativismo.
Questo dovrebbe essere appunto il fulcro di un codice deontologico: l’equilibrio tra asimmetria e simmetria del rapporto, tra libertà dell’individuo e responsabilità sociale, in cui paziente e professionisti sono entrambi coinvolti.
Questo nel 1903, ora cerchiamo di fare un passo avanti.
Stefano Rodotà, nel suo bellissimo articolo del 2015, L’uso umano degli esseri umani (MicroMega 8/2015, pp.121/166), offre spunti e considerazioni puntuali e profetici.
La tragedia del nazismo aveva messo in evidenza come questo rischio non valesse solo per fisici e chimici, ma anche per i medici e, vista la necessità di gestire i mezzi di propaganda, anche per gli studiosi della mente e del comportamento. Ricordiamo che l’inventore dell’eugenetica scientifica è stato F. Galton, personaggio di rilievo nella storia della psicologia.
È da quella esperienza che nel 1946 il codice di Norimberga, affrontando il tema della sperimentazione medica umana, asserisce che: “Il consenso volontario del soggetto è assolutamente necessario”.
Indicazione immediatamente accolta dalla Costituzione Italiana, che all’Art. 32 recita “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Qui cito Rodotà: “Viene cosi posto un limite invalicabile, più incisivo ancora, di quello previsto dall’articolo 13 per la libertà personale, che ammette limitazioni sulla base della legge e con provvedimento motivato del giudice. L’articolo 32 va oltre… è la sola volta in cui la Costituzione qualifica un diritto come <<fondamentale>>” (op. cit. p.123- 124). Nel suo articolo sottolinea come sia necessario frenare la tentazione di rincorrere una ”assoluta libertà della ricerca scientifica e dell’incondizionato riconoscimento del diritto della tecnologia come “libertà morfologica” in nome di una presunta utilità/indispensabilità delle “nano-bio-info-neuro-macchine”(op. cit. p.125).
Questo è il punto centrale per il nostro discorso: l’anima antica dell’uomo aspira da sempre ad essere Dio attratto dal desiderio di potere, controllo sociale ed economico.
È nella seconda metà dell’800 che, cercando di sottrarre questo ruolo alla religione e alla filosofia, la figura dello scienziato del comportamento guadagna un posto nuovo nello studio e nella visione dell’uomo. Il modello metodologico di riferimento diventano la fisica e la matematica. Dunque parole d’ordine: cause materiali individuabili come cause certe dei comportamenti, misurabilità dei fenomeni studiati. Quello ancora oggi prediletto che viene chiamato evidence based.
Il primo laboratorio sperimentale viene ascritto a W. Wundt, a Lipsia nel 1879. Ma non possiamo certo dimenticarci né di Pavlov, né di Watson, né di Darwin, che avevano impostato il loro modo di considerare lo studio della psicologia appunto secondo le leggi prese a prestito dalla fisica e dalla matematica. È qui che lo studio del cervello, come sede materiale dai comportamenti, e della genetica, come processo di trasmissione di essi, prende avvio.
Questo approccio materialista e meccanicista, nel costruire teorie su cosa sia la mente, la distinzione tra comportamento normale o patologico o sottosviluppato e come poterlo misurare controllare e selezionare è ancora oggi fondante della psicologia comportamentale o cognitivo-comportamentale e della neuro-psichiatria organicista. Dunque, in questa prospettiva, è lo studioso della mente che sa e conosce i motivi del comportamento, il paziente è relegato in posizione passiva spinto ad affidarsi all’”esperto”.
Si giunge così ai primi decenni del ‘900
È da quella visione dell’uomo che prende forma il magnifico romanzo di Aldous Huxley, Il nuovo mondo, del 1932. Si resta meravigliati della nitida fotografia di scenari di organizzazione sociale che anche oggi ci vengono proposti, inclusa l’idea che sia possibile costruire a piacimento una precoce identità sessuale nei bambini, senza tuttavia occuparsi del loro sviluppo emotivo, considerato un intralcio all’impalcatura dell’ordine di una società “perfetta”. Huxley non a caso pone nel Gotha della gerarchia sociale del romanzo la figura dello psicologo, che con la sua competenza è chiamato a far funzionare i progetti di eugenetica e controllo mentale.
Torniamo al filo rosso del tempo
Gli anni ’60 sono quelli in cui si allarga il dibattito che agita tutta la storia della psicologia e delle diverse teorie della mente formulate per affrontare l’enigma della mente umana: cos’e il comportamento cosciente e la distinzione tra normale e anormale, tra sano di mente e matto. È infatti dalla definizione stessa di sofferenza mentale che dipende il come trattarla e come considerare colui che manifesta sofferenza psichica nel rapporto tra razionalità ed emozioni. Consideralo un “non in grado di intendere e di volere” e dunque essere legittimati a decidere per lui, o…?
È il momento più acuto del dibattito tra diritto al rispetto del soggetto e necessità di controllo sociale.
Infatti anche la psicoanalisi pone il problema della necessità di restituire autonomia e centralità al paziente, cambiando concetti e metodi di trattamento. Ma soprattutto emerge l’impronta dell’esistenzialismo che si oppone all’idea di analisi come frammentazione dell’individuo chiuso in un involucro soggettivo, opponendo la pratica della psicosintesi. Qui troviamo le connessioni con l’esistenzialismo di sinistra cui si ispirerà anche Basaglia collegato al gruppo inglese di Laing ed Esterson. È in questa visione della sofferenza che al paziente viene restituito il diritto di autodeterminarsi e che modifica il rapporto tra professionista e utente.
È nel tentativo di superare la contrapposizione tra aspetti soggettivi e aspetti socio-culturali, ma soprattutto di cercare una strada di accesso più efficace per affrontare la sofferenza mentale grave, il Golem della psichiatria, la psicosi, che sempre in quegli anni nasce la sistemica con la teoria ecologica della mente formulata da Gregory Bateson. È la ricerca di un una cornice epistemologica più ampia, scientificamente fondata, interdisciplinare e utile ad affrontare la complessità della mente e delle sue manifestazioni.
Entriamo negli anni ’70
Per quel ramo della psicologia che accoglieva la visione della scienza materialista classica, allora come oggi, il soggetto doveva accettare la sua diversità, affidarsi e obbedire per il suo bene all’operatore. Il “malato mentale” è ancora visto come un “fuori norma”, misurabile con test o criteri classici ritenuti oggettivi a cui il DSM si riferisce ancora oggi (prima edizione 1952, ultima, la 5, del 2013 ora R).
Ma quelli sono anche gli anni del vero punto di svolta:
nel 1971 finalmente vengono istituiti, dopo anni di discussione con una parte della classe medica psichiatrica i primi due corsi di laurea in psicologia in Italia, a Roma e Padova, all’interno della facoltà di Magistero. Nel 1978 dopo anni di dura lotta sulla riforma sanitaria, viene congedata la legge 180, che prevede l’abolizione degli “ospedali speciali”, i manicomi.
In Italia, tra i movimenti fautori di questo cambiamento culturale spiccano il gruppo milanese di Mara Palazzoli Selvini e il movimento di psichiatria democratica fondato da Franco Basaglia. Entrambi ci verranno a lungo invidiati e assunti come modello. Specie nel mondo tedescofono e oltre oceano, negli USA e in America Latina.
Quel momento straordinario si caratterizzava proprio per il capovolgimento di quel rapporto paternalistico, denunciato già nel codice del 1903.
Ma ci vorranno più di dieci anni perché la legge istitutiva dell’Ordine degli Psicologi veda la luce: la legge 56/1989 e si dovrà attendere il 1995 perché venga istituita la facoltà di psicologia, dando a questa disciplina un totale riconoscimento.
Ed ora? Quale lo stato di autonomia, dignità e responsabilità di essa? Quale responsabilità e tutela gli psicologi si assumono verso i pazienti/cittadini?
Ci troviamo di fronte ad un nuovo punto di svolta o a un dietrofront?
Oggi è d’obbligo pensare a Umberto Eco e al suo libro Passo di gambero, del 2006. Infatti con gli anni duemila inizia una fase caratterizzata da un’enorme euforia da illusione di progresso e cambiamento epocale, che tuttavia agli osservatori più attenti mostra immediatamente il volto seduttivo dell’ambiguità. L’entusiasmo per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale come supporto al sogno transumanista viene visto da Rodotà (op. cit.) come la via che potrebbe portare ad un uso umano degli esseri umani per creare l’uomo aumentato. E dal matematico e fisico Lucio Russo come la legittimazione di una “persistente diffusione di una fede cieca nel progresso, che qualifica ipso facto come “progressivo” qualsiasi mutamento abbastanza forte da imporsi” (p.11). … “un processo che sottrae intelligenza al lavoro” (p.17) dunque sottrae competenza intelligente anche ai professionisti della salute mentale. (Lucio Russo,1998, Segmenti e bastoncini. Dove sta andando la scuola, Feltrinelli, Milano 2016).
Questa infatuazione spiega il vezzo con cui è sempre più dilagante preferire il termine neuropsicologi a quello di psicologi. Dove una parte (il neurone, il cervello) diventa più importante del tutto (la mente-corpo nel loro completo e inscindibile rapporto all’interno di un contesto umano e sociale).
Éric Sadin, nel suo saggio del 2016 analizza quella che definisce la psicopatologia della Silicon Valley. (La silicolonizzazione del mondo. L’irresistibile espansione del liberismo digitale, (2016) Einaudi, Torino, 2018)
“Si tratta di una vera e propria visione del mondo, fondata sul postulato tecnico-ideologico di una fondamentale inadeguatezza umana, destinata a essere colmata dall’intelligenza artificiale grazie a poteri sempre più vari ed estesi che le vengono affidati” (p.20) e che si caratterizza per “il disinteresse per gli effetti sociali.” (p.25).
È in questo Zeitgeist che troviamo una perversa saldatura tra biologico e sociale in cui gli psicologi sono tornati ad essere, come negli anni ’60, subalterni alle discipline mediche, testisti certificatori, pronti ad inviare a neuropsichiatri infantili e psichiatri i nuovi disabili del secondo millennio: DSA, ADHD, oppositivi-provocatori, soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico,… Aprendo la carriera psichiatrica a ben il 25% della popolazione scolastica, considerata non curabile e solo controllabile. (M. Gandolfi, A. Negri, Disturbi specifici (della relazione) dell’apprendimento. Un approccio ecologico alla didattica, alla diagnosi precoce e all’intervento sui DSA, G. Fioriti, 2023)
In quest’ottica il consenso informato e il riconoscimento dell’utente/paziente come attore attivo degno di agire una scelta consapevole diventa un vero intralcio. Dunque è comprensibile quanto contenuto nel tentato nuovo codice deontologico degli psicologi. Attendiamo quello dei medici! In nome del mai morto paternalismo c’è chi può decidere al posto di chi chiede aiuto, decidere per il suo bene e di una fantomatica comunità etero definita.
È impossibile non cogliere come proprio il contenuto del tentato nuovo codice deontologico delinei il ritorno ad una visione esclusivamente biologica e meccanicistica dell’uomo a cui anche una certa psicologia ha scelto di aderire. (Festival della salute ottobre 2023, Marco Cavallo
https://orax.me/blog/forum_art_det.asp?id=126&estrai=tutto )
Ma se si vuole sbandierare la garanzia scientifica dobbiamo rivolgerci a scienziati seri.
Così Guido Tonelli, fisico tra gli scopritori del bosone di Higgs:
“La fisica del XX secolo archivia definitivamente ogni tentazione di realismo grossolano e di meccanicismo materialistico… (p. 173) … “L’illusine di capire il funzionamento del cervello umano usando gli stessi strumenti che ci hanno permesso di capire il funzionamento di altri nostri organi è tramontata da tempo…Il metodo scientifico non è in discussione…(ma)… balbetta, o risulta del tutto impotente, nell’affrontare i fenomeni privi di queste caratteristiche. (Come appunto la vita di)… una comunità umana di individui pensanti, liberi e interagenti fra loro non può essere trattato come un sistema fisico” (p.175). (Materia. La magnifica illusione, Feltrinelli, Milano, 2023)
Dunque non meno scienza ma più scienza, quella vera che usa il metodo come autocorrezione ed è interessata alla conoscenza e non al potere, per tutelare dignità, libertà e responsabilità sia dei cittadini sia dei professionisti che se ne occupano.