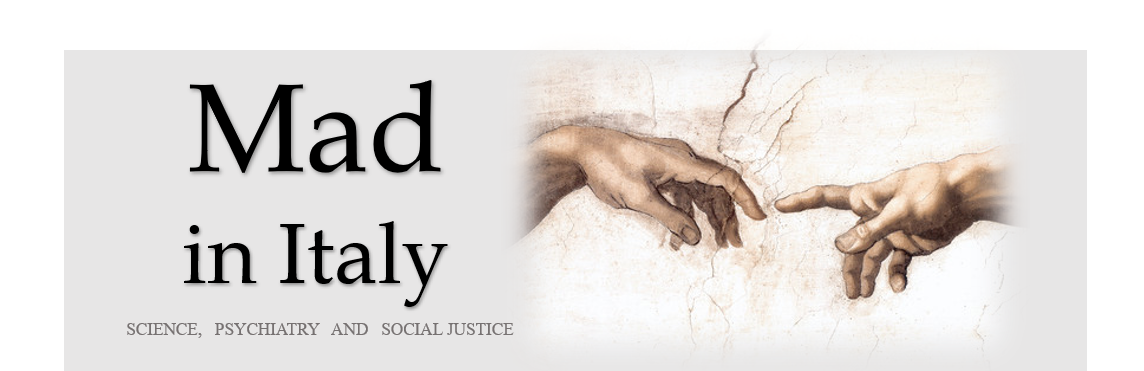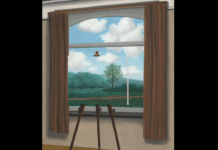- Psicofarmaci dietro le sbarre: la deriva psichiatrica del sistema penitenziario italiano - 2 Ottobre 2025
- Quando la cura offusca il quadro clinico: riconoscere le sindromi psichiatriche iatrogene nella medicina di base - 14 Agosto 2025
- Quando l’Antidepressivo Mima la Malattia: Il Caso delle Mioclonie Indotte da antidepressivi SSRI - 21 Giugno 2025
Psicofarmaci dietro le sbarre: la deriva psichiatrica del sistema penitenziario italiano
Un’indagine clinica e politica sull’uso improprio dei farmaci nelle carceri
Introduzione: la psichiatria come strumento di controllo
Nel sistema penitenziario italiano, la psichiatria sembra perdere la sua vocazione terapeutica per assumere una funzione di contenimento e controllo. L’articolo di Marcello Maviglia, pubblicato su Journal of Psychology & Clinical Psychiatry, esplora con rigore e passione questa trasformazione, denunciando l’uso sistemico e spesso improprio di psicofarmaci nelle carceri italiane.
La tesi centrale è chiara: i farmaci psicotropi, in particolare antipsicotici e benzodiazepine, vengono somministrati non per gestire delle diagnosi psichiatriche che rispettino i seppur discutibili criteri diagnostici, ma per sedare comportamenti ritenuti problematici, gestire il sovraffollamento e compensare la carenza di personale sanitario.
Contesto storico e istituzionale
La chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) nel 2015 avrebbe dovuto segnare una svolta epocale: la fine della segregazione manicomiale e l’inizio di un approccio più umano e integrato alla salute mentale in ambito penale. Le REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) erano nate con questo intento, ma si sono dimostrate insufficienti ai bisogni degli utenti, sottofinanziate e molto spesso inaccessibili.
Il risultato? Un ritorno mascherato alla logica manicomiale, dove il carcere diventa il nuovo contenitore della sofferenza psichica. In assenza di strutture adeguate, i detenuti con disturbi mentali finiscono in celle comuni, prive di supporto terapeutico, e spesso trattati con psicofarmaci come unica risposta, ovviamente con conseguenze deleterie.
Dati allarmanti e pratiche cliniche discutibili
L’articolo documenta una serie di dati e pratiche che sollevano interrogativi etici e clinici:
- Fino al 70% dei detenuti riceve psicofarmaci, spesso senza una diagnosi chiara o una valutazione multidisciplinare.
- Gli antipsicotici vengono usati off-label, cioè al di fuori delle indicazioni cliniche approvate, per sedare agitazione, rabbia o comportamenti oppositivi.
- Le benzodiazepine sono distribuite con leggerezza, nonostante il rischio di dipendenza, effetti cognitivi e interazioni farmacologiche.
- Il tempo medio di presenza dello psichiatra è inferiore a 7 ore settimanali per 100 detenuti, rendendo impossibile una presa in carico terapeutica, che possa indagare sulle ragioni psicosociali del loro disagio emotivo.
- I suicidi in carcere sono in aumento: 91 nel 2024, 33 già nel primo semestre del 2025. Dati che riflettono sia una gravissima sofferenza individuale, che un vero e propeio fallimento sistemico.
Focus sui detenuti immigrati: tra esclusione e medicalizzazione
Particolarmente vulnerabili sono i detenuti immigrati, che rappresentano il 32% della popolazione carceraria. Per loro, le barriere linguistiche e culturali si traducono in diagnosi affrettate, trattamenti coercitivi e isolamento. La psichiatria, anziché essere ponte di cura, diventa strumento di esclusione e di vera e propria medicalizzazione.
Spesso, il disagio sociale, la marginalità e il trauma migratorio vengono interpretati come sintomi psichiatrici e trattati con farmaci anziché con ascolto, mediazione culturale e interventi relazionali. Il risultato è quello di una medicalizzazione del disagio sociale, che confonde il sintomo con il la sperienza di vita del detenuto.
Una crisi etica: la psichiatria tra cura e complicità
L’autore richiama con forza i principi fondamentali dell’etica medica:
- Autonomia: i detenuti non partecipano alle decisioni terapeutiche, spesso non comprendono le diagnosi né i farmaci che assumono.
- Più danni che benefici: i trattamenti causano danni iatrogeni, dipendenza, effetti collaterali e perdita di autodeterminazione.
- Giustizia: l’accesso alle cure è diseguale, discriminatorio e spesso subordinato alla logica penale.
La psichiatria, in questo contesto, rischia di diventare complice di un sistema punitivo, anziché garante di diritti e promotrice di salute.
Proposte di riforma: verso una psichiatria etica e relazionale
L’articolo non si limita alla denuncia, ma propone una serie di riforme concrete e urgenti:
- Supervisione indipendente delle pratiche psichiatriche in carcere, con audit clinici e valutazioni etiche.
- Formazione interculturale per gli operatori, per evitare diagnosi errate e trattamenti inappropriati.
- Accesso a interventi non farmacologici: psicoterapia, gruppi di parola, attività espressive, rituali di cura.
- Integrazione dei servizi psichiatrici penitenziari nel Servizio Sanitario Nazionale, per garantire continuità terapeutica e standard clinici.
Conclusione: una chiamata alla responsabilità
La domanda che attraversa l’articolo è profonda e scomoda: può la psichiatria essere strumento di cura in un contesto che nega la libertà, la dignità e la relazione? E cosa significa, oggi, “cura” in un sistema che privilegia la sedazione alla comprensione del disagio emotivo?
L’articolo ci invita a ripensare radicalmente il ruolo della psichiatria in carcere, a restituirle la sua vocazione relazionale, narrativa e comunitaria. È un appello alla responsabilità clinica, politica e umana.
Articolo originale (PDF):