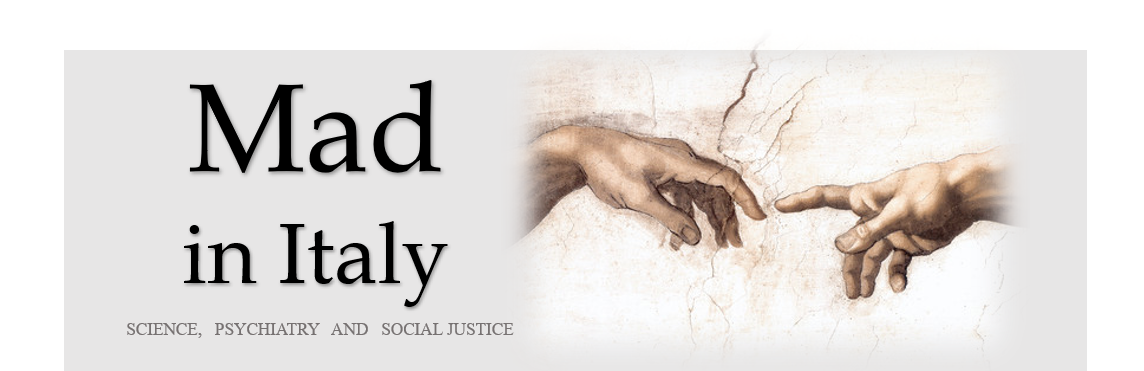- Arte come cura – arte come terapia – di Renato Ventura - 21 Luglio 2025
- A proposito dell’articolo Diagnosi alla psichiatria di Susanna Brunelli: crisi della psichiatria o degli psichiatri? – di Renato Ventura - 20 Luglio 2025
- A proposito dell’articolo di Miriam Gandolfi: Il nuovo codice deontologico degli psicologi – Linee guida per una psicologia di Stato? - 21 Giugno 2025

Arte come cura – arte come terapia
Tratto dalla RELAZIONE ALLA TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA DAL MUNICIPIO 5 PER LA SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE 2022 (MILANO 08.10.2022)
SALUTE MENTALE: IL CONTRIBUTO DEI LINGUAGGI E DELLE PRATICHE ARTISTICHE
Innanzitutto una breve definizione terminologica: terapia è una branca della medicina che tratta dei mezzi e delle modalità usate per combattere le malattie.
Cura (in inglese “care”) indica invece un impegno assiduo e diligente nel provvedere a qualcuno (o qualcosa).
Nel caso dell’Arteterapia noi preferiremmo utilizzare il termine di cura in quanto, come vedremo, abbiamo qualche dubbio circa l’effettiva possibilità di una terapia che possa risolvere la problematica complessa del disturbo mentale grave. A questo proposito ribadiamo la nostra ferma convinzione che non di malattia mentale si tratta bensì di disturbo. Anche il noto DSM denomina tali alterazioni disease, cioè disturbo (DSM è l’acronimo di Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disease).
Tenterò di tenere insieme tre concetti per non disperdermi in un universo a me non ben conosciuto, quello dell’arte, e non rischiare di uscire di strada.
I concetti sono:
- Il legame, a mio parere importante, tra l’arte primitiva – o perlomeno le espressioni iconografiche (graffiti) degli uomini primitivi – le produzioni, sempre di tipo artistico delle popolazioni primitive africane, australiane e del Sudamerica, i disegni dei bambini e la c.d. art brut.
Per l’arte preistorica si vedano, a titolo di esempio, le impronte di mani del 30.000-10.000 a.C. ca. di una pittura rupestre. (Grotta delle Mani Dipinte, Rio Pinturas, Chubut, Patagonia (Argentina) e i dipinti rupestri della Grotta di Chauvet in Francia (bisonti e altri animali oggi scomparsi), che è uno dei più noti e importanti siti preistorici europei, ricco di testimonianze, simboliche ed estetiche, del Paleolitico superiore (Aurignaziano). È il più antico esempio di arte preistorica del mondo.
I disegni dei bambini li conosciamo tutti e sono spesso primitivi e schematici e assomigliano a quelli degli uomini primitivi.
Infine la cosiddetta Art Brut: è il nome dato da Dubuffet a pitture, disegni, oggetti eseguiti da pazienti ospiti dei vecchi ospedali psichiatrici, bambini, persone comunque estranee a un ambiente culturale e prive di qualunque educazione artistica.
Il concetto di art brut è che tali espressioni siano di ispirazione artistica autonoma e incolta.
- Il multiverso. L’altro elemento che cercherò di collegare a queste produzioni artistiche è la mia convinzione che gli psicotici vivono in un mondo a parte, in una loro realtà diversa da quella comune, non dirò normale perché il termine di normalità psichica, a mio parere, in psichiatria e psicopatologia, va abolito. Effettivamente gli psicotici hanno un caratteristico distacco dalla realtà (dereismo) e vivono in una condizione detta delirante (da de-lira: uscire dal solco o lira). Abitano un universo parallelo, che in astronomia si chiama multiverso. Infatti secondo alcune teorie astrofisiche, c’è la possibilità che esista un insieme ipotetico di universi coesistenti, di cui anche il nostro farebbe parte. Non è da confondere con il sempre più citato metaverso, che ha qualche affinità con l’universo parallelo, perché il multiverso si definisce come uno spazio virtuale in cui le differenze con la realtà diventano quasi impercettibili.
- Arte e follia. Il terzo elemento che cercherò di illustrare è la possibilità che, attraverso l’arte gli psicotici, ma in generale gli artisti, esprimono e mettono in forma comunicativa il loro mondo interno con il mondo esterno. E’ spesso l’unica forma di comunicazione. Gli artisti tali sono proprio in quanto hanno elementi di originalità che si discosta dal sentire comune. Non è un caso che molti artisti abbiano tratti psicotici più o meno importanti e viceversa. Fra tutti Van Gogh è l’esempio più noto. Ma anche Ligabue (rappresentante dell’art naif), di cui ho visto recentemente un bel film, era chiaramente una persona molto disturbata psichicamente. Sono solo due esempi fra i tanti che si potrebbero citare. Ambedue avevano avuto, tra l’altro, una infanzia assai travagliata: Van Gogh aveva sostituito nella mente della madre un fratello morto prematuramente e Ligabue era stato abbandonato e adottato.
La Klein, con il disegno, costruiva un setting nel quale poi, sulla base delle informazioni del bambino (Richard) circa i significati che attribuiva al disegno, interpretare le sue fantasie inconsce. E’ un po’ come con i sogni che Freud notoriamente impiegava per cercare di accedere all’inconscio del paziente È nota la sua definizione di sogno come porta d’ingresso dell’inconscio. In realtà ho poi capito che non è che si possono Interpretare i sogni come si leggono i tarocchi o i fondi di caffè. Il sogno è un materiale grezzo attraverso il quale poi il terapeuta con le “associazioni libere” entra nel mondo interno del paziente.
Credo che anche chi interpreta i fondi di caffè o fa i tarocchi o pratiche similari si basi fondamentalmente sulla sua capacità di entrare in empatia col paziente, i suoi bisogni, le sue paure e le sue fantasie. In tal modo, essendo dotato di capacità naturali di sintonizzarsi empaticamente con le persone che cercano una soluzione ai loro problemi, utilizza questi strumenti, di tipo esoterico, che gli permettono di relazionarsi con lui.
Anche i disegni degli uomini primitivi sulle grotte sono un modo di tradurre graficamente le forme e le situazioni (la caccia) che colpivano la loro fantasia e un modo per affermare sè stessi.
Un discorso simile può essere fatto per le tribù primitive che abitano ancora in zone isolate dell’Africa, dell’Oceania e del Sud America (nella Foresta Amazzonica). Non è un caso che alcuni artisti moderni abbiano utilizzato queste espressioni primitive di tipo artistico per riportarle, attraverso la loro sensibilità di uomini occidentali, nella loro opera artistica: si veda Gauguin e il suo rapporto con la Polinesia e si veda Cy Twombly e la sua produzione artistica che ricorda i disegni (anche gli sgorbi) dei bambini. All’inizio degli anni cinquanta, Twombly apprende il linguaggio visivo dell’Espressionismo astratto, gestuale e lirico, al Black Mountain College (NC), e lo associa all’interesse per la storia e la letteratura del mondo classico. Le sue composizioni, dal carattere non premeditato, ma controllato, evocano la scrittura spontanea.
È evidente però lo iato fra l’aspetto creativo e gli aspetti comunicativi e relazionali che il gesto artistico, ma anche le altre forme di comunicazione non verbale, evoca. In sostanza, per venire al titolo dell’intervento che mi è stato proposto, nel gesto artistico e creativo bisogna distinguere fra vari livelli e diverse angolazioni prospettiche.
E’ chiaro l’intento comunicativo e socializzante del gesto creativo.
C’è però un livello e una prospettiva che cerca di esprimere invece un mondo separato e personale abitato dei propri fantasmi. E’ quello che io chiamo multiverso, da non confondere con il metaverso che, come abbiamo detto, con il primo ha qualche affinità. Per multiverso io intendo la possibilità che il mondo abitato dagli psicotici sia un mondo parallelo, con grande difficoltà di relazionarsi con il mondo dei cosiddetti “normali”. Ho già detto che la normalità in psicologia e in psichiatria non esiste e se noi apprezziamo l’opera d’arte è perché esprime una fantasia o una creatività non comune e non banale (l’originalità dell’artista). Anche in noi c.d. “normali” (ma ripeto che non esistono persone normali) esiste una zona (io parlerei di un nucleo psicotico più o meno importante e che può essere alla base della creatività, la Klein parla di posizione schizo-paranoide), che coglie il singolare, talora bizzarro, originale, creativo modo di percepire la realtà che viene trasfigurato nell’opera d’arte.
Il sociologo Luca Negrogno dell’Istituzione Minguzzi usa spesso, nei suoi scritti, il termine neurodivergenza per indicare la naturale variazione tra un cervello e l’altro nella specie umana. E’ un concetto simile a quello che ho proposto di multiverso dello psicotico. La neurodivergenza fa riferimento però a un modello biologico (la biodiversità) più che psicologico e ingloba le persone autistiche e le persone con problematiche di genere. Per esempio una persona neurodivergente interna alla comunità LGBT+ (come ad esempio un individuo autistico e trans) viene detto neuroquer.
In casa ho una tempera di Dova che era stata regalata a mia moglie dal noto pittore quando, ormai 50 anni fa, faceva una sorta di doposcuola ai suoi figli. E’ molto bella e decorativa ma è una espressione geometrica con un accostamento di colori molto delicato. Qual è il significato?
Una mia paziente psicotica seguita in Comunità, scrive poesie. I medici del CPS mi dicono che è meglio della Merini, da loro conosciuta in passato. Io fatico a leggerle e a capirle.
Da un mese sono consulente presso una comunità terapeutica psichiatrica. Ho conosciuto ieri Claudio, 58 anni, schizofrenia paranoide cronica. Nella sua cartella clinica è scritto “eccentrico e bizzarro nell’abbigliamento e nelle modalità espressive”. In realtà l’ideazione è tipicamente dissociata e usa neologismi come nella cosiddetta schizofasia (una sorta di insalata di parole). Nella sua cartella clinica si legge anche che” si isola avviluppato nei propri pensieri e percezioni psicopatologiche, ha allucinazioni uditive (mi ha detto che sente le voci dei bambini) e lo aiuta nella loro gestione l’espressione creativa in un modo artistico, anche se talvolta fortemente bizzarro”.
Il libro che mi ha prestato, nel quale viene citata la sua biografia e riportate alcune sue opere parla di artisti come lui e si intitola: “Sono altro, sono altrove”.
L’opera artistica ma anche il banale disegno e tutte le espressioni che hanno a che fare con la libera espressione creativa (disegno, canto, musica, teatro, scultura, ceramica…) sono allora espressione di questo mondo parallelo.
Questi tre esempi, Dova, la mia paziente, la poetessa psicotica e Claudio, che mi sono venuti alla mente in occasione di questo invito, mostrano la difficoltà, almeno per me, di accedere a questo mondo alternativo ma anche l’opportunità, attraverso l’opera d’arte o la poesia o una modalità espressiva alternativa, di entrare in relazione con questo mondo.
Mi dice Claudio: “L’arte è in contatto con il campo astrale” Chiedo di spiegarmi: “Van Gogh era schizofrenico. Questo vuol dire che l’alterazione genetica della schizofrenia appartiene ai luoghi chiusi della mente ove proliferano il surreale, l’astratto e il demiurgo”. Perché demiurgo chiedo. Risponde: “perché è una forza latente”. Un altro appunto del colloquio: “Tante scatole dentro di noi che sono le voci, bisogna dare un nome artistico a questa cosa…”.
Effettivamente è allucinato e forse, se ho ben capito le sue parole, anche probabilmente forzando la loro interpretazione, mi dice che effettivamente ci sono luoghi chiusi della mente cioè quello che io chiamo un mondo isolato e personale e difficilmente comunicabile, dove appunto entra il discorso artistico (il surreale, l’astratto e il demiurgo). Forse mi vuole dire che ci sono forze estranee (il demiurgo) a lui che entrano nella sua mente. E’ una condizione molto diffusa in questi artisti che vivono appunto l’espressione creativa non come elaborazione di una loro personale fantasia ma come una forza che si impadronisce di loro e si esprime in modo autonomo utilizzando la loro persona come tramite. Molto frequente è l’idea di essere posseduti e tramite di forze spirituali (il frequente “spiritismo” associato a queste forme espressive) o “intergalattiche” (come si esprime nel libro che mi ha prestato Claudio un altro artista dell’art brut) o dai morti (lo spirito dei morti) o, come dice Claudio, “con il campo astrale”.
Ritorno, per concludere e sperando di non avere troppo deviato, al titolo che mi è stato suggerito (Arte come terapia-arte come cura), dicendo che non credo che l’arte possa essere terapia, nel senso proprio che si dà in medicina al termine terapia. Forse si può parlare di autoterapia, ma nel senso di un modo come altri (abbracciare gli alberi, cantare, disegnare, danzare, fare yoga, eccetera) di esprimere le proprie fantasie e i propri demoni (vedi Hieronymus Bosch) ma anche di controllare e gestire in questo modo i propri fantasmi inconsci.
Vedo meglio invece il termine cura. Utilizzare cioè nel setting, come la Klein ha fatto con il suo bambino, per accedere al suo inconscio e alle sue ansie e alle paure concrete (l’analisi di Richard avveniva sotto i bombardamenti aerei tedeschi su Londra e il bambino faceva disegni che riproducevano gli eventi bellici) il disegno o la produzione artistica, come modalità per relazionarsi con il paziente e, attraverso le sue associazioni, interpretare i suoi stati d’animo (il suo inconscio) non verbalizzabile. Nello stesso modo, nella seduta analitica, si utilizza la produzione onirica (il sogno) che viene interpretata con associazioni libere che paziente produce in seduta e la si interpreta secondo il ben noto modello freudiano (transfert e controtransfert, ecc.).
Analogamente nella Arteterapia credo che debba prevalere Il piacere e l’interesse reciproco fra l’arte-terapeuta e il paziente a utilizzare l’espressione artistica (o qualunque modalità espressiva) non tanto per fare terapia (non esiste la terapia della schizofrenia e probabilmente non esiste neanche la schizofrenia come malattia), quanto per permettere al paziente di aprirsi alla relazione con l’Altro (l’arte-terapeuta e il gruppo di Arteterapia), riversando nell’opera artistica o nelle sue espressioni non verbali comunicative la sua creatività: le “pagliuzze d’oro”, come le ho definite, che hanno gli psicotici se, come i cercatori d’oro, abbiamo la pazienza e la tenacia di raccoglierle.
In questa prospettiva la relazione diventa cura o meglio, come si usa dire oggi, un” prendersi cura”, nel senso cioè di farsi carico del paziente che ci consegna una parte di sé inaccessibile o che ci apre al suo mondo interno (che è il suo mondo). In questo modo si può talora stabilire una relazione nella quale noi ci prendiamo cura di lui, ma anche lui ci dà qualcosa di sé: le pagliuzze d’oro…
Dott. Renato Ventura